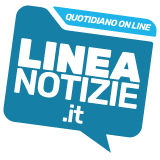“Colazione da Tiffany” (Breakfast at Tiffany’s), diretto da Blake Edwards nel 1961, è l’immagine di Audrey Hepburn in tubino nero, con collana di perle e occhiali da sole oversize, mentre osserva sognante la vetrina di Tiffany & Co. sulla Quinta Strada di New York.
Un’icona immortale di stile.
Eppure, ridurre questo capolavoro a un mero manifesto di eleganza sarebbe un errore. Sotto la superficie scintillante, “Colazione da Tiffany” è un’opera agrodolce e complessa, un ritratto commovente di due anime perse che cercano disperatamente un posto nel mondo.
Il film ci introduce a Holly Golightly (Audrey Hepburn), una giovane donna eccentrica, affascinante e apparentemente spensierata che vive nel cuore di Manhattan.
La sua vita è un caotico turbine di feste, uomini ricchi e fughe dalle proprie responsabilità.
Sopravvive grazie alla generosità dei suoi ammiratori, che lei chiama “topi” (“rats”), e sogna di sposare un milionario per trovare finalmente la stabilità.
Il suo unico rifugio dalla “tremarella” (le sue crisi d’ansia) è la gioielleria Tiffany, simbolo di un mondo ordinato, lussuoso e sicuro.
La sua routine viene sconvolta dall’arrivo di un nuovo vicino, Paul Varjak (George Peppard), uno scrittore in crisi creativa che, proprio come Holly, vive di espedienti: è l’amante di una ricca donna più anziana (Patricia Neal).
Tra Holly e Paul nasce un’immediata complicità. Lui è affascinato dal suo spirito libero e dalla sua vulnerabilità nascosta; lei trova in lui un confidente, qualcuno che non la giudica e che vede oltre la sua maschera.
Il loro legame si approfondisce attraverso avventure bizzarre, come una giornata passata a fare cose mai fatte prima, culminata con il furto di due maschere da un negozio di cianfrusaglie.
Ma il passato di Holly non tarda a riaffiorare con l’arrivo di Doc Golightly, l’uomo che aveva sposato quando era solo un’adolescente di nome Lulamae Barnes, fuggita da un’infanzia difficile in Texas.
Questo incontro rivela la profonda frattura tra la donna che Holly finge di essere e la ragazza spaventata che è in realtà.
Decisa a non farsi “ingabbiare”, Holly allontana Paul e si concentra sulla conquista di un ricco politico brasiliano.
Ma quando un suo vecchio legame con un gangster in prigione la mette nei guai, il suo castello di carte crolla.
In una delle scene più celebri e strazianti del cinema, sotto una pioggia battente, Holly abbandona il suo gatto senza nome in un vicolo, simbolo del suo rifiuto di ogni legame.
Sarà Paul, con un discorso potente sull’amore e l’appartenenza, a costringerla finalmente a guardarsi dentro.
Il cuore del film risiede nella complessità dei suoi protagonisti.
Holly Golightly è uno dei personaggi femminili più iconici e complessi della storia del cinema.
È una “phony”, una falsa, come lei stessa ammette. La sua vita è una performance studiata per nascondere la paura e l’insicurezza. La sua eccentricità, il suo glamour e la sua apparente noncuranza sono un’armatura contro un mondo che l’ha ferita.
Sotto l’armatura si nasconde Lulamae Barnes, una ragazza spaventata dalla povertà e terrorizzata dall’idea di essere ingabbiata in una vita normale. La sua ricerca di un marito ricco non è avidità, ma un disperato tentativo di trovare sicurezza.
Il gatto, che lei si rifiuta di nominare, è il suo alter ego: indipendente, randagio e senza padrone (“Non appartengo a nessuno e nessuno mi appartiene”).
Tiffany’s rappresenta un’ideale irraggiungibile di pace e ordine, un luogo dove “non può accaderti nulla di male”. Audrey Hepburn, con la sua grazia innata, ha ammorbidito il personaggio rispetto al romanzo originale di Truman Capote, rendendola più vulnerabile e amabile, ma senza cancellarne l’essenza tormentata.
Paul Varjak non è il classico eroe romantico, ma lo specchio di Holly.
Anche lui è un “mantenuto”. Vive una vita che non gli appartiene, compromettendo la sua integrità artistica e personale. Questa sua condizione gli permette di capire Holly a un livello profondo, senza giudicarla.
Paul è l’unico che si prende il tempo di guardare oltre la maschera di Holly. Vede la sua fragilità e se ne innamora. A differenza degli altri uomini, non vuole possederla o usarla, ma amarla per quello che è.
È lui a pronunciare le parole chiave del film: “Le persone si innamorano, le persone si appartengono a vicenda, perché questo è l’unico modo per essere felici”. Rappresenta la possibilità di un amore autentico che non si basa sul denaro, ma sulla reciproca accettazione.
Nonostante vivano in una metropoli vibrante, sono profondamente soli. Il loro viaggio è la ricerca di un “luogo” – o meglio, una “persona” – da poter finalmente chiamare casa. Il film mette in scena l’eterno conflitto tra la ricerca della stabilità economica e la resa all’imprevedibilità dei sentimenti.
La regia elegante di Blake Edwards, la fotografia patinata di New York e, soprattutto, la colonna sonora immortale di Henry Mancini, con la struggente “Moon River”, contribuiscono a creare un’atmosfera magica e malinconica.
È impossibile non menzionare l’unica, grande nota stonata del film: la rappresentazione caricaturale e razzista del personaggio del signor Yunioshi, interpretato da Mickey Rooney, un aspetto oggi giustamente criticato ma che va contestualizzato nell’epoca in cui il film fu prodotto.